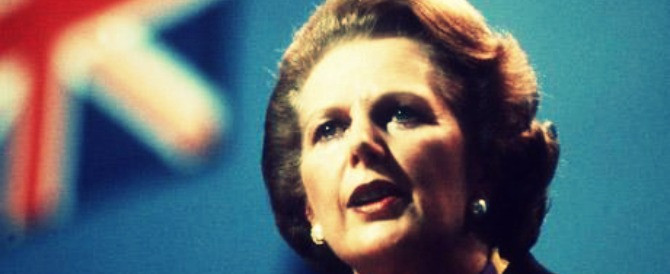Per creare lavoro una legge non basta
Massimo Riva – L’Espresso
Dice il ministro dell’Economia che le novità previste con la legge di Stabilità dovrebbero portare a 800 mila nuove assunzioni nel corso del prossimo triennio. Ne saremmo tutti oltremodo felici, anche perché l’Istat ha appena certificato che dal 2008 ad oggi sono andati perduti oltre due milioni di posti di lavoro soltanto nella fascia di età fra i 25 e i 34 anni. Riassorbirne cosi tanti nell’arco di trentasei mesi si offre come una prospettiva entusiasmante. Forse anche un po’ troppo. perché c’è il rischio di alimentare speranze che potrebbero rivelarsi illusioni con ricadute negative sulla credibilità di un governo che, in realtà, qualcosa di buono e di utile per il rilancio della crescita economica sta facendo.
È fuor di dubbio, infatti, che almeno un paio di novità introdotte nella manovra per il 2015 dovrebbero avere effetti positivi in termini di creazione di posti di lavoro. Non solo i nuovi assunti a tempo indeterminato costeranno meno quanto a oneri contributivi ma le imprese potranno anche godere di un robusto sgravio dell’Irap proprio sul versante del lavoro. Perciò è senz’altro ragionevole pensare che il combinato disposto di queste due misure possa schiudere in ingresso quei portoni di fabbriche e uffici che da tempo sono aperti soltanto in uscita. Ma declamare cifre così imponenti come fa il governo è operazione politica temeraria anche perché l’esperienza storica indica che un rientro significativo della disoccupazione è possibile soltanto quando il tasso di crescita annuo si avvicina ad almeno un paio di punti percentuali, non agli stentati decimali previsti per l’anno venturo e seguenti. Non c’è impresa disposta ad assumere lavoratori perfino a costo zero se il mercato dei suoi prodotti non si rianima. In altre parole, se la domanda per consumi non riprende a ritmi vivaci.
E qui siamo a un primo punto dolente. L’orso della crisi dell’occupazione si sta rivelando un animale sempre più difficile da addomesticare con gli strumenti tradizionali e da parte di un singolo domatore. immaginare che oggi il mercato del lavoro possa essere rilanciato soltanto con interventi legislativi su fiscalità e oneri contributivi significa non aver compreso appieno la vastità e la profondità del problema. Per carità, in momenti difficili tutto serve: a cominciare da un buon bricolage legislativo come quello proposto dal governo. Ma con queste riforme si adempie una prima condizione, sicuramente necessaria e però anche del tutto insufficiente. In un sistema economico esposto alla combinata minaccia di una recessione sommata alla deflazione non si esce da una simile tenaglia – mortale per l’occupazione – senza produrre sforzi rilevanti sul versante degli investimenti, dapprima pubblici e a seguire privati.
E qui siamo al secondo, essenziale, passaggio. Oggi non esiste l’ipotesi di perseguire efficacemente la crescita economica da soli e in casa propria: non lo consente l’integrazione con il mercato unico europeo e ancor più la globalizzazione economica planetaria. Ovvero: l’Italia può risalire la china solo all’interno di un concerto europeo nel quale la musica deprimente del mero rigore contabile venga sostituita da uno spartito che preveda un piano di grandi investimenti collettivi e di rilancio della domanda interna.
Conta, dunque, poco che Parigi si ribelli al limite del tre percento sul disavanzo o che Roma voglia procrastinare l’ingresso nella gabbia del pareggio di bilancio. Fino a quando si incrociano le armi attorno alla maggiore o minore sacralità dei vincoli europei si continua a restare dentro il gioco degli idolatri di un codice di regole concepito e sottoscritto in tempi (ormai lontani) di benessere crescente per tutti. Oggi l’orizzonte è cambiato. L’obiettivo degli 800mila posti di lavoro declamato dal ministro Padoan può diventare realistico a una condizione su tutte prevalente: che qualcuno in Europa riesca a rovesciare il tavolo di una politica economica che, dietro il vessillo dell’euro forte e dell’austerità, sta rendendo tutti più poveri.