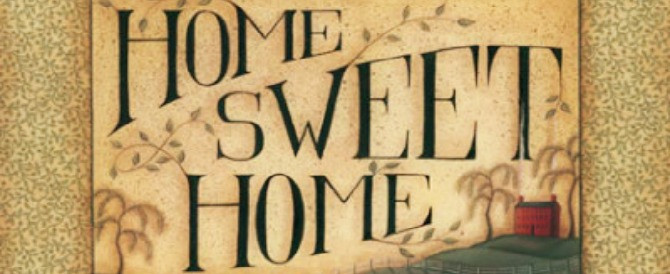La vera riforma dell’articolo 18
Franco Debenedetti – Il Sole 24 Ore
Che abbia ragione chi sostiene che quella sull’articolo 18 è una battaglia ideologica, perché a difendere i diritti di chi lavora ci sono fortini giuridici, e a frustrare gli interessi degli imprenditori lo Stato provvede con mezzi ben più intrusivi? A far sorgere il dubbio è la questione dei licenziamenti disciplinari. Una sorta di residuo secco tra i licenziamenti discriminatori, – che mai nessuno si è sognato di legittimare – e quelli per giustificato motivo economico – per cui non ci andava molto a capire che il giudice non è la persona adatta a decidere.
È quindi comprensibile che in questa battaglia politica, i licenziamenti individuali siano il contenitore delle riserve mentali: sia di quanti pensano di conquistare riformismo con i decreti delegati sia di chi conta di recuperare garantismo nei tribunali. Se diventassero il contenitore di casi ambigui nella definizione e incerti nella risoluzione, questa sarebbe davvero stata soltanto una battaglia ideologica interna alla sinistra. Per evitarlo c’è una strada molto semplice: stabilire senza equivoci che per tutti i cosiddetti licenziamenti disciplinari l’azienda ha il diritto a sostituire l’eventuale reintegro con un indennizzo di entità nota ex ante.
Infatti nella via di un’impresa sono rari i casi in cui per sopravvivere deve licenziare, delocalizzare, oppure ridurre l’occupazione (fini per cui tra l’altro si possono attivare già altri strumenti). Rari i casi di disoccupazione tecnologica: già Sismondi, due secoli fa, ironizzava con chi teme que le roi, demeuré tout seul dans l’ile, en tournant constamment une manivelle, fasse accomplir, par des automates, tout l’ouvrage de l’Angleterre. Rari sono anche i casi opposti, in cui l’azienda aumenta gli organici perché è riuscita a invadere nuovi mercati, oppure perché ha sbaragliato la concorrenza con un’innovazione. La gran parte delle aziende, per la massima parte della loro vita, procede per variazioni incrementali, una nuova filiale di vendita, una macchina più veloce, un’organizzazione del lavoro più efficiente: la metodica, incessante, noiosa ricerca di fare le cose in modo più produttivo. Rare sono le inaugurazioni di nuovi capannoni, rare per fortuna le chiusure, la normalità è migliorare marginalmente ogni fase di ogni attività: e questo significa anche trovare persone marginalmente più capaci di svolgerle.
Fare squadra non è soltanto la qualità mitizzata di leader mitizzati, lo fanno tutte le cellule delle organizzazioni: e nessun allenatore riesce a fare squadra se la sola soluzione di cui dispone è allungare la panchina. Per questo, i miglioramenti marginali di efficienza sono «giustificato motivo economico» per licenziamenti individuali: se anche ci fosse ricorso al giudice e questo ordinasse il reintegro, l’azienda deve potere optare per l’indennizzo. È vero, l’azienda è, per storica definizione, luogo dello scontro di classe; è anche, per umane ragioni, luogo di abrasioni caratteriali: dietro il licenziamento disciplinare ci può essere una meschina ripicca, una stupida vendetta. Ma la fabbrica è anche il luogo in cui ognuno è nodo di un reticolo complesso di relazioni, verticali e orizzontali, anche i rapporti gerarchici sono trasformati dalla generale disintermediazione: sarebbe proprio stupido rischiare di danneggiare un ambiente sociale con una palese ingiustizia.
Recuperare produttività è il cuore del problema italiano. Molto dipende dai servizi erogati dallo Stato, quindi dal funzionamento dello Stato stesso, molto dalla produttività delle singole aziende. Per le poche che sono leader mondiali nei loro settori, per le tante che cercano di tenere il mare, l’aumento della produttività è un processo incrementale, che si basa sulla continua ottimizzazione delle funzioni e sulla selezione di chi meglio le sa svolgere. La produttività dell’Italia ristagna da 15-20 anni, rispetto ad aumenti molto più congrui dei paesi concorrenti: eppure il governo sembra voler lasciare a questo proposito le cose come stanno, non far nulla per facilitare questo processo di miglioramento interno.
Le nuove norme, e quindi anche il considerare «giustificato motivo economico» i miglioramenti marginali di efficienza, non si applicheranno a chi oggi ha un contratto a tempo indeterminato. E nella nostra cultura giuslavoristica rimarrà per anni il principio della job property, che la riforma avrebbe dovuto sradicare. Se per i casi di licenziamento disciplinare non si desse all’azienda la possibilità di procedere per l’indennizzo in luogo del reintegro, e se questa comunque non valesse per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato fino alla loro pensione, ci sarebbe veramente da interrogarsi sul perché di tanta contestazione a una legge che estende diritti a molti (dipendenti di aziende con meno di 15 persone, lavoratori non a tempo indeterminato, contratto di reinserimento per tutti) e non ne leva a nessuno. Verrebbe da dire che questa è stata una finta battaglia, ingaggiata soltanto per poter dire di averla vinta.