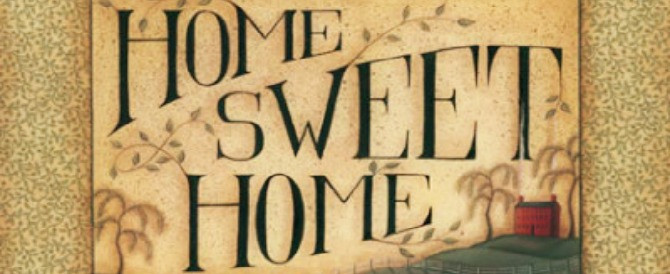Casa, tassati e maltrattati
Massimo Fracaro e Nicola Saldutti – Corriere della Sera
Benjamin Franklin, inventore del parafulmine e uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, considerava le tasse come una delle due cose inesorabili della vita. Da noi, quando si parla di tasse, c’è una terza cosa a cui sembra quasi impossibile sottrarsi: la complicazione per pagarle. I cittadini (non i sudditi, come spesso sono considerati) avrebbero sempre il diritto di sapere l’entità delle imposte da versare. E di conoscere questo dato in tempo sufficiente per poter programmare come distribuire i propri redditi tra i consumi, il risparmio, il rispetto dei doveri verso lo Stato e i Comuni.
Nel caso delle imposte sulla casa di questa pratica, che dovrebbe essere di ordinaria amministrazione in un Paese con rapporti equilibrati tra Fisco e cittadini-contribuenti, sembriamo essercene dimenticati. È successo per l’Imu nel 2012 e nel 2013. È successo per la Tasi – la tassa sui servizi comunali alla collettività nel suo insieme – nell’estate scorsa e sta succedendo anche adesso, alla vigilia dell’autunno. E se tre indizi fanno una prova come diceva Agatha Christie… A meno di un mese dalla scadenza, 3.100 Comuni su oltre 8.000 non hanno ancora fissato l’aliquota della nuova tassa dovuta dai proprietari immobiliari e, in qualche caso, dagli inquilini. La scadenza per decidere è fissata per domani, mentre la delibera comunale dovrà essere pubblicata sul sito del ministero delle Finanze entro il 18 settembre. Se la delibera viene pubblicata in tempo utile, la prima rata della Tasi andrà versata entro il 16 ottobre (e il saldo a dicembre). Se il Comune non fa in tempo, allora i cittadini interessati dovranno passare alla cassa direttamente a dicembre e pagheranno le aliquote standard e la Tasi in unica soluzione. Ma non è finita. Perché alcuni sindaci, virtuosi, avevano già chiuso la pratica Tasi a maggio e hanno già incassato la prima rata a giugno (a dicembre incamereranno la seconda). Insomma un ginepraio di regole e di scadenze che finisce per disorientare. Un’incertezza tributaria che frena i consumi e fa aumentare il risparmio improduttivo. Per non parlare, poi, della difficoltà di reperire, sul sito delle Finanze, l’aliquota Tasi, considerato il tono burocratico delle delibere. E la loro mole. Quella del Comune di Milano, relativa a tutte le tasse locali, è di 63 pagine.
Certo anche per i Comuni, alle prese con difficoltà di bilancio, non dev’essere stato facile impostare la politica fiscale, stabilire quali categorie esentare o quali detrazioni immaginare, ma i cittadini non si meritano di dover vivere in una simile Babele delle imposte in versione federal-comunale. Altro che bollettini precompilati, come promesso. Si è sempre sostenuto che, avvicinando le tasse e gli enti impositori ai cittadini, le cose sarebbero migliorate e la trasparenza complessiva sarebbe aumentata. Purtroppo non sembra sia andata così, almeno finora.
Complicato anche fare i confronti tra Tasi e Imu. E rispondere alla domanda che interessa tutti: pagherò di più? La sensazione è che la Tasi finirà per essere una tassa regressiva: inciderà, in proporzione, di più sugli immobili di minor valore e sulle famiglie con i redditi più bassi perché le detrazioni non sono paragonabili a quelle in vigore con l’Imu. La tassa regressiva, probabilmente, neanche l’eccelsa mente di Franklin sarebbe riuscito a inventarla.