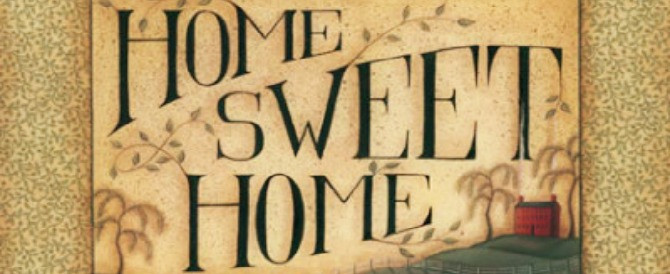Rivoluzione catastale: abitazioni rivalutate in futuro anche del 180 per cento
Roberto Petrini – La Repubblica
Scatta l’operazione catasto, una vera e propria rivoluzione, attesa da anni, che porterà alla revisione delle rendite catastali di oltre 60 milioni di immobili. Al taglio del traguardo, tra circa cinque anni, i valori catastali potrebbero subire rivalutazioni dal 30 al 180 per cento, ma l’obiettivo è quello di colpire soprattutto chi fino ad oggi ha pagato di meno per case di maggior prestigio. Il decreto legislativo varato ieri definitivamente dal consiglio dei ministri, dopo l’esame del Parlamento, avvia il primo passo. Ripartono le nuove «commissioni censuarie» provinciali: 106 organismi composti da membri dell’Agenzia delle entrate, dell’Anci e dei professionisti (geometri, fiscalisti, ingegneri ecc.) che avranno il compito nei prossimi cinque anni di stimare casa per casa, capannone per capannone, le nuove rendite catastali, misura cruciale per calcolare l’imponibile sul quale si pagano Imu, Tasi e Irpef. Da segnalare che il decreto prevede che non saranno corrisposti gettoni di presenza.
Il decreto varato ieri è tuttavia solo il primo passo, importante perché le Commissioni erano di fatto congelate dal 1989, che crea l’infrastruttura decisionale dell’intera operazione. Il secondo, che si attende prima di marzo del prossimo anno quando scadranno i termini per l’esercizio della delega, fornirà i nuovi meccanismi di calcolo che terranno conto del valore di mercato mandando in pensione i vecchi estimi calcolati in base ad «ingessate» zone censuarie e categorie catastali (le famose A1, A2 ecc). Al posto del sistema archiviato ne arriverà uno nuovo che si articolerà in tre classi principali: abitazioni, attività produttive e immobili ad uso sociale. Il calcolo si baserà sui metri quadrati e non più sui vani, ma terrà conto di una serie di variabili in grado di definire il reale valore dell’immobile avvicinandolo al prezzo di mercato: si valuterà per definire il nuovo «algoritmo» della presenza di scale, dell’anno di costruzione, del piano, dell’esposizione e della localizzazione.
Naturalmente le rendite catastali e gli imponibili fiscali non potranno che lievitare, ma la legge delega assicura l’invarianza di gettito: dunque ci sarà da aspettarsi un intervento selettivo. Al traguardo gli immobili situati nelle zone di prestigio o residenziali, con vecchie rendite catastali che consentono un peso fiscale ancora relativamente basso, pagheranno di più rispetto ad immobili periferici della stessa categoria. «La riforma dovrà sanare gli squilibri che oggi esistono, squilibri per cui due case molto simili, se non uguali, pagano tasse differenti in virtù delle diverse collocazioni catastali. Pur con l’invarianza di gettito appare quindi ovvio che, domani, ci sarà chi pagherà più rispetto ad oggi e chi meno. Ieri pagava molto chi aveva poco e pagava poco chi aveva molto», spiega Mirco Mion, presidente dell’Agefis, l’associazione dei geometri fiscalisti. Secondo un recente studio della voce.info l’applicazione dei nuovi criteri per la determinazione della rendita determina un aumento significativo e generalizzato della base imponibile delle imposte immobiliari, a testimonianza della distanza tra le tariffe d’estimo e i valori di mercato. Nelle grandi città il rapporto tra le due rendite potrebbe variare in un intervallo compreso tra 4 e 7.
I calcoli che vengono fatti dall’Agefis, l’associazione dei geometri e fiscalisti, che raffrontano la media degli attuali valori catastali (cioè l’imponibile sul quale si calcolano le tasse da pagare) di categorie A2 e A3 (l’80 per cento del mercato) con le stime dei nuovi valori «agganciati » al mercato, lasciano presagire un rincaro generalizzato: si andrebbe da una media del 30 per cento ad Aosta, fino al 180 per cento a Bolzano e Salerno, passando per un aumento del 150 per cento a Napoli. Prosegue intanto il cammino della legge di Stabilità alla Camera: nel mirino l’anticipo del Tfr in busta paga che è stato oggetto di una serie di emendamenti di tutti i gruppi parlamentari, dal Pd, a Forza Italia a M5S. Il Pd chiede in particolare la neutralità fiscale che chi opta per l’anticipo rispetto a chi arriva a fine percorso, tutti chiedono di eliminare l’aumento della tassazione per fondi pensione e liquidazione, mentre un emendamento del Pd chiede l’estensione della misura anche agli statali.