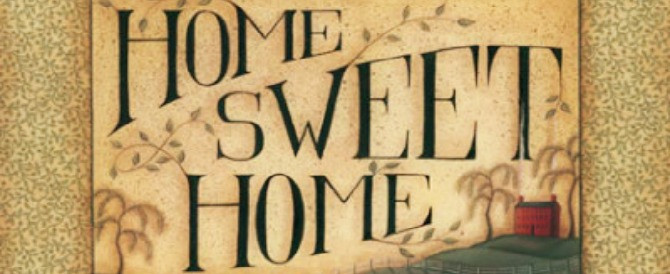Tutte le sberle del PD sul mattone
Luciano Capone – Libero
Matteo Renzi ha sconvolto i tradizionali schemi politici e dice cose che sono da sempre nelle corde dell’elettorato di centrodestra sul ruolo dei sindacati, sull’articolo 18, sulla burocrazia, sulle riforme istituzionali. Ma qualche differenza forse esiste ancora, ad esempio sul tema fiscale, dove tendenzialmente la destra preferisce tasse più basse rispetto alla sinistra. La conferma arriva dai risultati di uno studio di due economisti italiani che lavorano a Harvard, uno di fama internazionale, Alberto Alesina, e uno giovane, Matteo Paradisi, che hanno analizzato l’effetto dei cicli elettorali sulla scelta dell’aliquota Imu da parte dei Comuni. Dai dati emerge che i Comuni di centrosinistra tassano di più di quelli di centrodestra, o meglio che è più alta la percentuale di Comuni di centrosinistra che hanno alzato l’aliquota Imu.
Il lavoro di Alesina e Paradisi non si occupa delle differenze tra destra e sinistra, ma di vedere se e quanto i Comuni sono influenzati nella scelta dell’imposizione fiscale dalle scadenze elettorali. Gli economisti sono partiti dall’introduzione dell’Imu nel 2011 per vedere come si sono comportate le amministrazioni locali nell’applicazione della parte variabile dell’aliquota Imu. La scelta di studiare l’Imu, nonostante le difficoltà a spiegare il meccanismo dell’imposta al pubblico internazionale, è giustificata per la parziale autonomia di cui dispongono i Comuni nella scelta dell’aliquota, perché è un’imposta con un gettito rilevante (circa 24 miliardi di euro), che interessa un’ampissima fetta di contribuenti (circa 26 milioni), in un Paese in cui oltre il 60% delle famiglie ha una casa di proprietà. La ricerca mostra l’esistenza di un «ciclo elettorale», ovvero la scelta da parte degli amministratori di abbassare le tasse prima delle elezioni per essere riconfermati e questo effetto è più evidente nei piccoli Comuni e nel Sud Italia. Nei piccoli Comuni perché si trovano a gestire problemi meno complessi e quindi l’Imu assume un’importanza più rilevante nel dibattito politico; per quanto riguarda l’Italia meridionale la spiegazione è di tipo culturale: nel Sud c’è minore «coscienza civica», partecipazione alle decisioni pubbliche e controllo sugli amministratori e quindi l’elettorato è più manipolabile dai politici, che basano le loro scelte sulla base del ciclo elettorale.
Ma i dati più interessanti, anche se occupano solo una parte della ricerca, sono quelli sulle differenze tra centrodestra e centrosinistra: al netto del ciclo elettorale, «la sinistra tende a imporre imposte più alte della destra». ll 35% dei Comuni amministrati dal centrosinistra ha scelto aliquote più alte di quella standard, contro il 27,6% del centrodestra. Mentre i pochi Comuni che hanno scelto di abbassare l’aliquota Imu sulla prima casa sono per l’8,4% di centrodestra e per il 6,5% di centrosinistra. E questo, spiegano gli economisti, «è coerente con le due diverse impostazioni ideologiche sulla tassazione della ricchezza». Un solo dato è in controtendenza: il 3% dei Comuni di sinistra ha deciso di abbassare l’aliquota sulle seconde case contro appena lo 0,2% dei Comuni di destra.