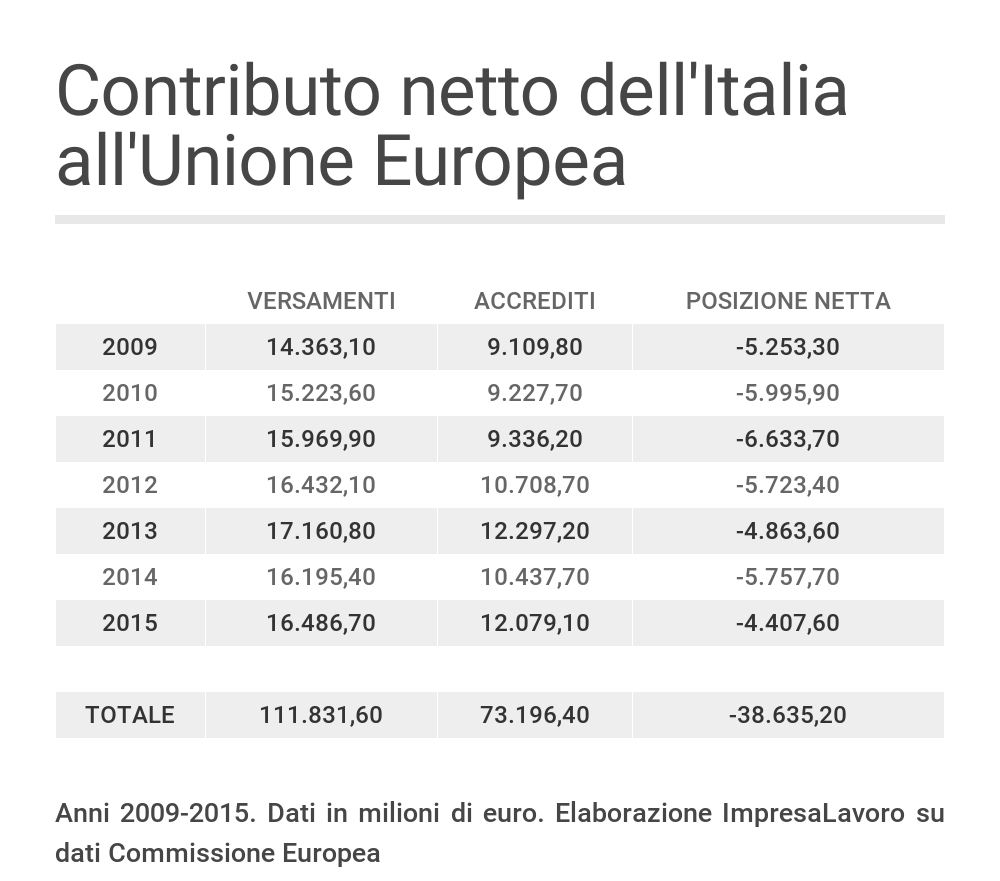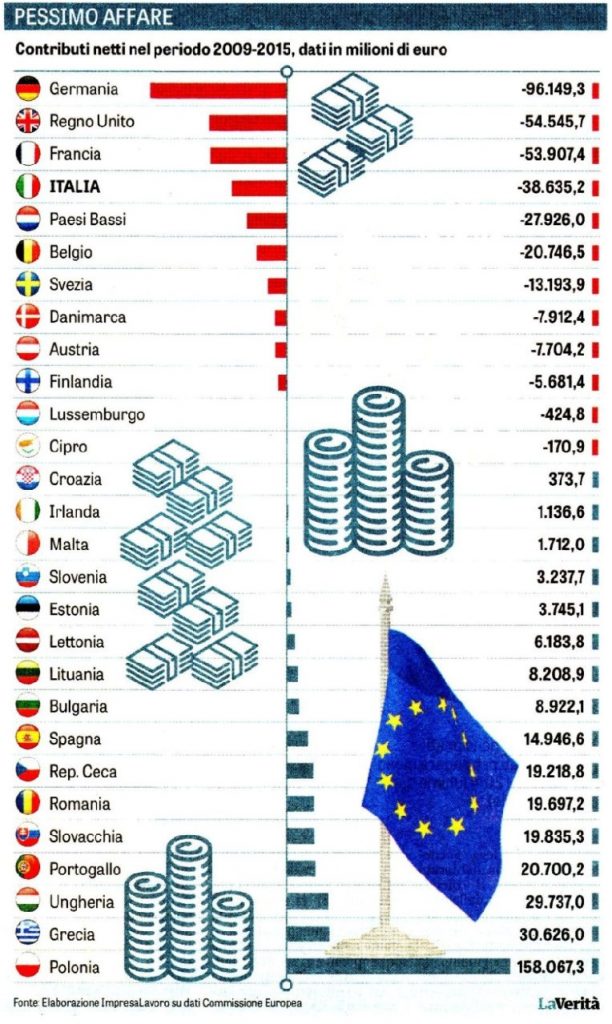Lasciateci liberi di scegliere un Inps “privato”
di Massimo Blasoni – Panorama
Il deficit di gestione ormai strutturale dell’Inps è l’emblema dell’insostenibilità del nostro impianto previdenziale. Nel 2016 il patrimonio netto dell’Istituto è andato per la prima volta in negativo: sei anni fa misurava oltre 40 miliardi. Lo scorso esercizio ci sono state perdite per 7,65 miliardi, in linea con quelle che si registrano ormai da anni. Il disavanzo, regolarmente ripianato dallo Stato, è frutto del disallineamento tra contributi versati – con il criterio della ripartizione, dai lavoratori di oggi – e pensioni pagate. A questo si aggiunge la notevole massa dei crediti che l’Inps non riesce ad incassare e che è costretto ciclicamente a svalutare: un po’ come avviene per i crediti deteriorati delle banche. Si tratta di cifre ingentissime che rappresentano un’ulteriore pesante ipoteca sul bilancio della previdenza nazionale.
È noto che il sistema retributivo applicato in passato fu troppo generoso ma la situazione attuale è anche frutto di una gestione non certo assennata del patrimonio immobiliare. Per dare un’idea, l’Inps possiede 25mila immobili valutati più di tre miliardi da cui però non trae alcun provento, anzi un rilevante deficit annuale. E purtroppo non è finita qui. La sostenibilità del sistema previdenziale richiede sia una crescita del Pil di almeno un punto e mezzo percentuale annuo, sia un indice di occupazione – cioè di partecipazione al mercato del lavoro – nettamente più alto di quello attuale. Risultati per il momento non conseguiti né sul piano della crescita, che in Italia resta modesta, né relativamente all’incremento dell’occupazione: solo il 57% degli italiani lavora, contro una media europea dieci punti più alta. Tra l’altro nel nostro Paese non ha grande spazio la previdenza complementare: fra coloro che versano contributi il tasso di adesione non supera il 25% del totale degli occupati. D’altro canto con netti in busta paga fortemente gravati dall’altissimo cuneo fiscale e previdenziale non è semplice per le famiglie ritagliare risorse per assegni aggiuntivi.
Le incertezze per il futuro gravano fondamentalmente sui giovani. Lavori discontinui, vuoti contributivi e una previdenza in genere penalizzante rispetto al passato rischiano di condurre ad assegni pensionistici miseri e a un lavoro che si dovrà protrarre sino ad un’età assai avanzata. Il fatto è che ancora oggi alcuni vanno in pensione a poco più di 50 anni mentre l’aspettativa per chi inizia a lavorare va ben oltre i 70 anni. Una soglia che potrebbe spostarsi ancora più in là, posto che ogni tre anni i coefficienti di trasformazione adeguano l’età di pensionamento alla costante crescita della vita media. Una considerazione conclusiva: non è frutto di un ordine necessario che debba essere lo Stato a gestire i nostri contributi obbligatori. Sarebbe forse preferibile che ci fosse data la possibilità di decidere liberamente dove investirli, optando tra soggetti pubblici e privati in concorrenza. Un passaggio complesso ma a ben vedere non impossibile.