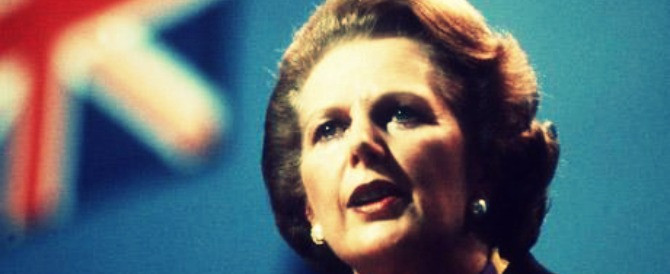La Cassazione ribalta le sentenze ragionevoli sulle tasse non pagate
Matteo Mion – Libero
La Cassazione penale non molla la presa. Il nuovo orientamento della giurisdizione di ultima istanza è ormai feroce nel sanzionare penalmente le inadempienze tributarie. La Suprema Corte sta pian piano chiudendo i varchi aperti dalle sentenze dei tribunali che si erano permessi di non condannare gli imprenditori rei di aver omesso il versamento di tributi a causa della crisi o del fallimento della propria azienda. In molti casi, infatti, i giudici di prime cure avevano ritenuto dovuta l’imposta, ma avevano chiuso un occhio sull’aspetto penalistico. Così il tribunale di Pescara con ordinanza del 29 ottobre 2013 non aveva attribuito rilevanza penale all’omesso versamento di Iva da parte del titolare di una ditta individuale che, come emergeva dalle scritture contabili, non aveva incassato l’imposta da due aziende, poiché una era fallita, l’altra era in procedura concordataria: un provvedimento logico e scritto con la penna del buon padre di famiglia. Hai fatturato l’Iva, ma non l’hai mai incassata: pagala, perché sei un pirla a non adeguare la contabilità, ma non ti condanno penalmente, perché non sei un delinquente.
Niente da fare, perché la Cassazione penale Sezione Terza con sentenza 863/2014 accoglie il ricorso presentato dalla Procura della repubblica di Pescara con la seguente motivazione: «il reato contestato non si realizza allorché l’imprenditore trattiene presso di sé le somme che egli ha ricevuto a titolo di Iva dai suoi aventi causa, ma allorché egli ometta di versare le somme quali risultanti dalla dichiarazione Iva da lui presentata, prescindendosi dalla effettiva percezione di esse da parte del contribuente che è pertanto tenuto a pagare l’imposta». Nessuna pietà contro gli imprenditori, nemmeno qualora sia provata la loro buona fede. Ci sarebbe molto da discutere sulla condotta di uno stato che esige l’Iva non percepita da un’azienda che non abbia adeguato la dichiarazione contabile, ma è senza dubbio canaglia lo stato che si accanisce penalmente contro un imprenditore, reo di non pagare le tasse sugli insoluti che lui stesso ha subito. Siamo alla follia gabelliera, alla polizia fiscale.
La magistratura dei palazzi romani è completamente distaccata dalla drammatica realtà economica del paese. Dopo un lauto banchetto e un sontuoso convegno, seduti sugli scranni fregiati della Suprema Corte capitolina, con stipendio sicuro e senza essere responsabili del loro operato, cinque giudici di massimo rango stabiliscono che D.P. è evasore per il reato penale di cui all’art. 10 ter D.lgs. 74/2000 e cioè l’omesso versamento d’imposte. D.P. invece non è un ladro, ma un italiano come tanti che fatica a tenere in piedi la baracca a causa della crisi e di una magistratura come questa.