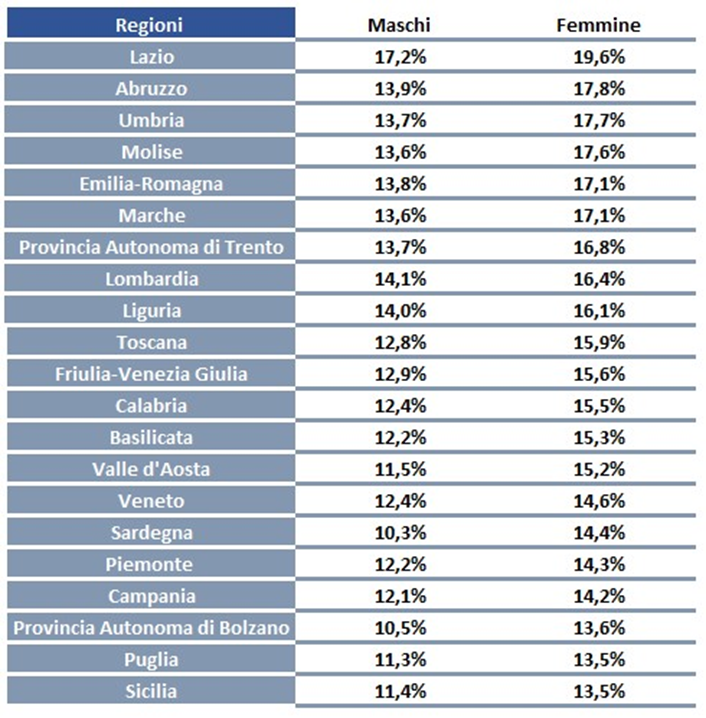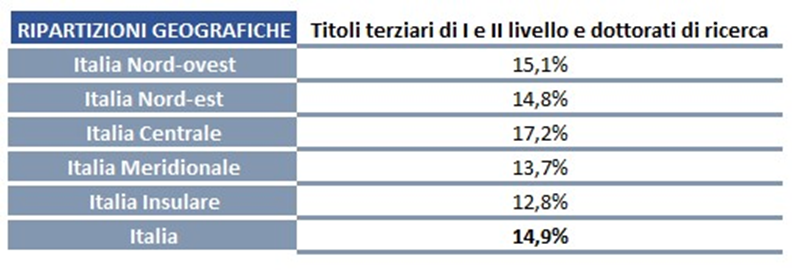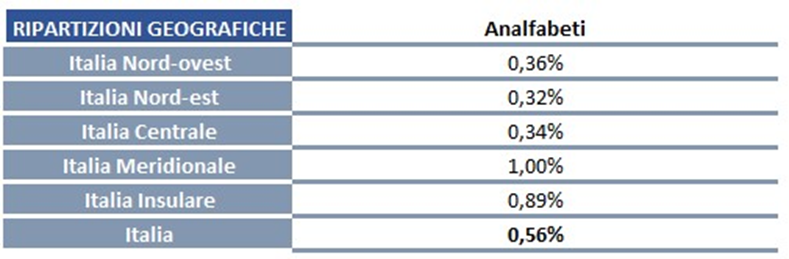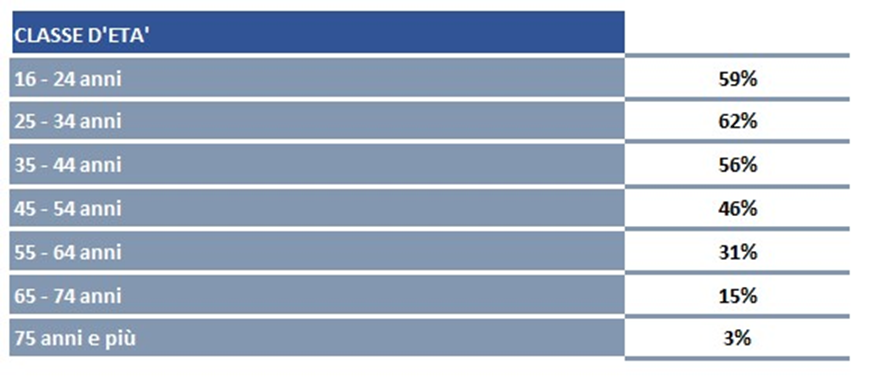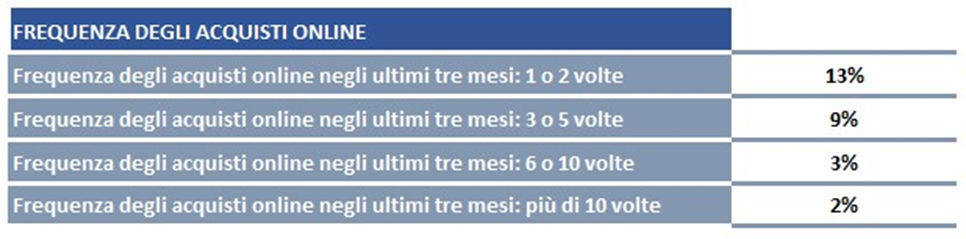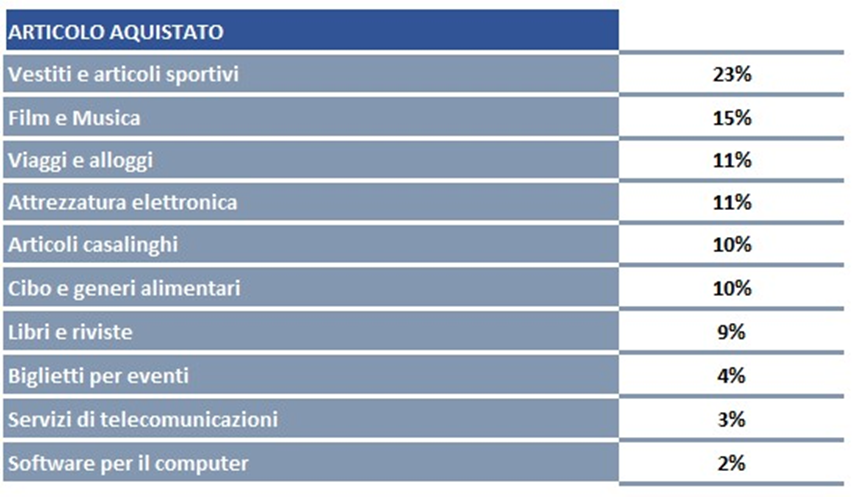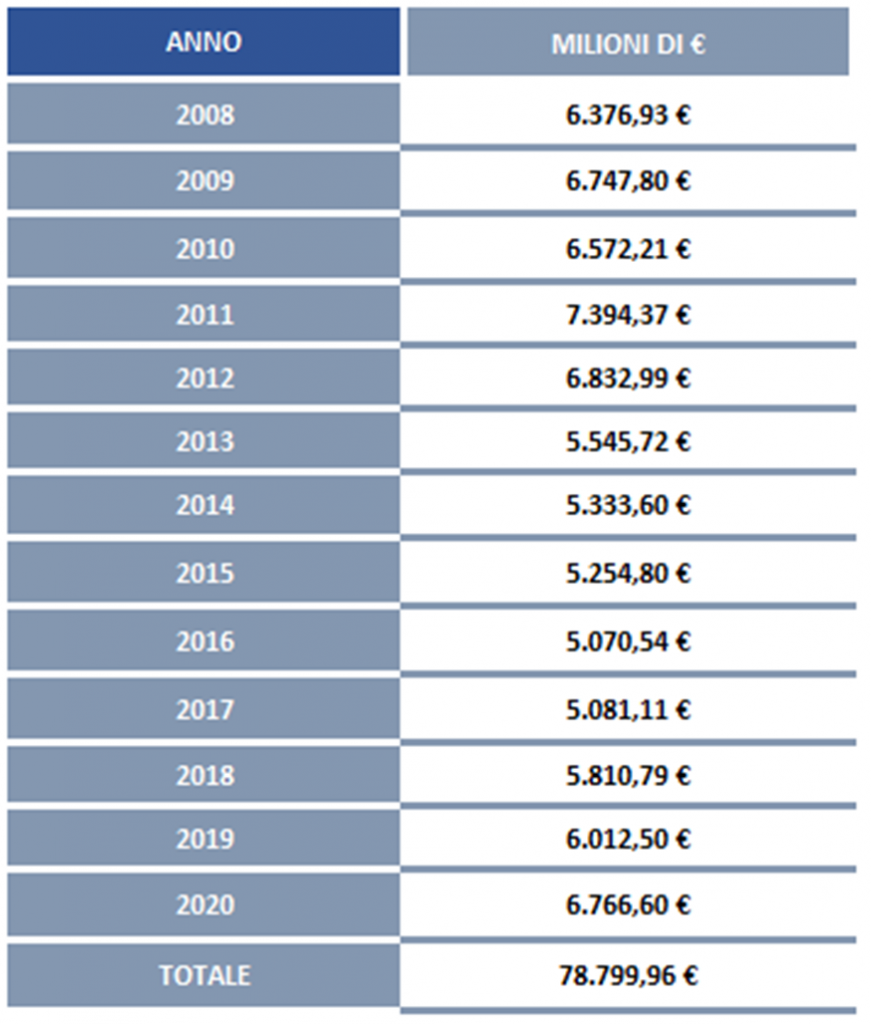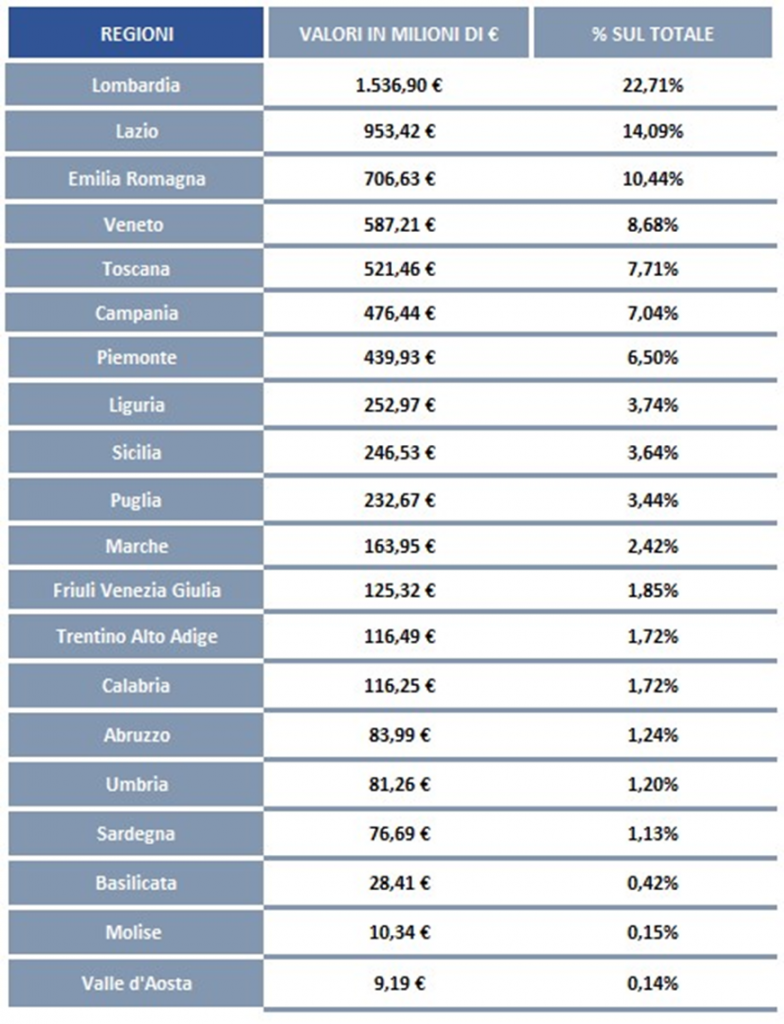Addio, Giuseppe
Sabato 8 aprile 2023 è scomparso Giuseppe Pennisi.
Stava con la sua famiglia. In queste settimane è stato circondato dall’affetto e dalla vicinanza di molti.
Nato a Roma nel 1942, orgoglioso di essere nominato Grand’Ufficiale all’Ordine al Merito della Repubblica. Ha avuto una prima carriera negli Usa (Banca mondiale) sino alla metà degli Anni Ottanta. Rientrato in Italia è stato Dirigente Generale ai Ministeri del Bilancio e del Lavoro e docente di economia al Bologna Center della Johns Hopkins University e della Scuola Nazionale d’Amministrazione, di cui ha coordinato il programma economico dal 1995 al 2009 quando è andato in pensione per limiti di età. In seguito, ha insegnato per quattro anni alla Università Link e per cinque alla Università Europea di Roma. È stato consulente della Cassa Depositi e Prestiti per cinque anni e consigliere del CNEL per otto anni.
Frequente collaboratore di quotidiani e periodici, ha scritto, in materia economica per anni per Il Sole24Ore, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, i quotidiani del Gruppo Finegli e dal 1994 regolarmente per Avvenire nonché dal 2010 per Il Sussidiario e Formiche, e per i periodici Mondoperaio ed IdeAzione.
Ha pubblicato una ventina di libri di economia e finanza in Italia, Usa, Gran Bretagna e Germania. Tra i suoi incarichi istituzionali, è stato consigliere d’amministrazione dell’Ipalmo, dello IAI, di Formautonomie e dell’Isfol, e componente dei consigli scientifici dell’ICE e dell’Università Europea di Roma, nonché del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e Paesaggistici.
Culture di musica classica, è stato Vice-Presidente del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e critico musicale del settimanale Liberal dal 1996 al 2001 e del settimanale Il Domenicale dal 2001 al 2011, nonché dei quotidiani e periodici del Gruppo Class dal 2000 al 2015, del mensile Musica delle testate Opera Today del 2007 al 2010 e Classical Music Vision dal 2010, nonché de Il Sussidiario, di Formiche, di Art Tribune, del mensile Classica e del trimestrale Nuova Antologia.
Dal 2014 era Presidente del Board scientifico del Centro Studi ImpresaLavoro, con cui ha collaborato negli anni costantemente. Il suo contributo è stato prezioso. Lo ricordiamo tutti con affetto e stima.
É stato un uomo dal pensiero libero e aperto al mondo.
Un caloroso abbraccio alla famiglia.
L’ultimo saluto sarà martedì 11 aprile 2023 alle ore 11 nella chiesa di San Gioacchino in Prati, a Roma.