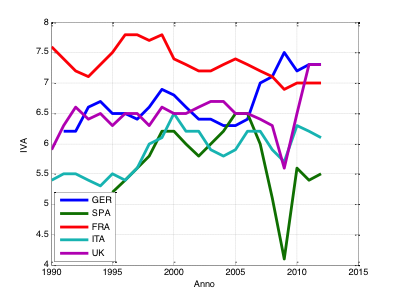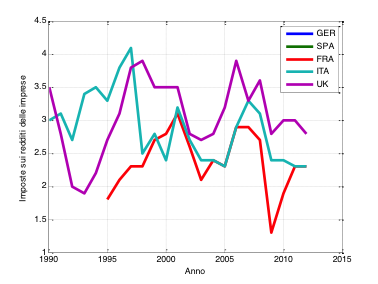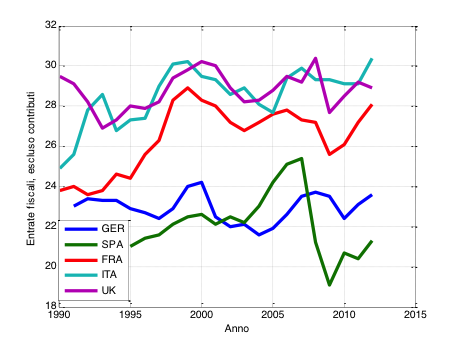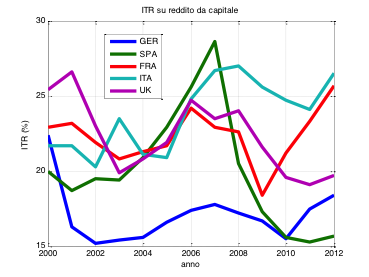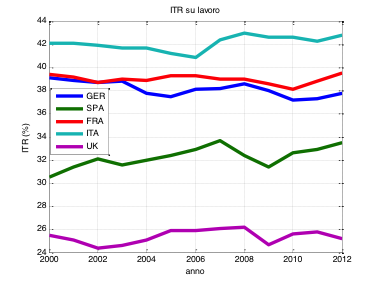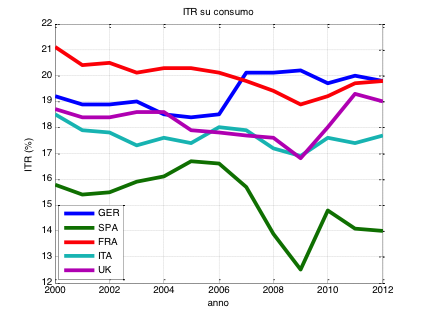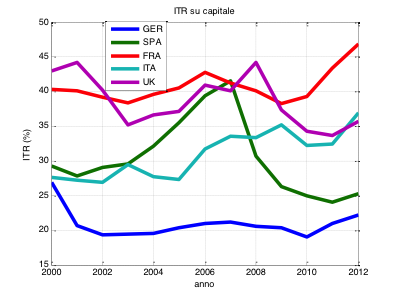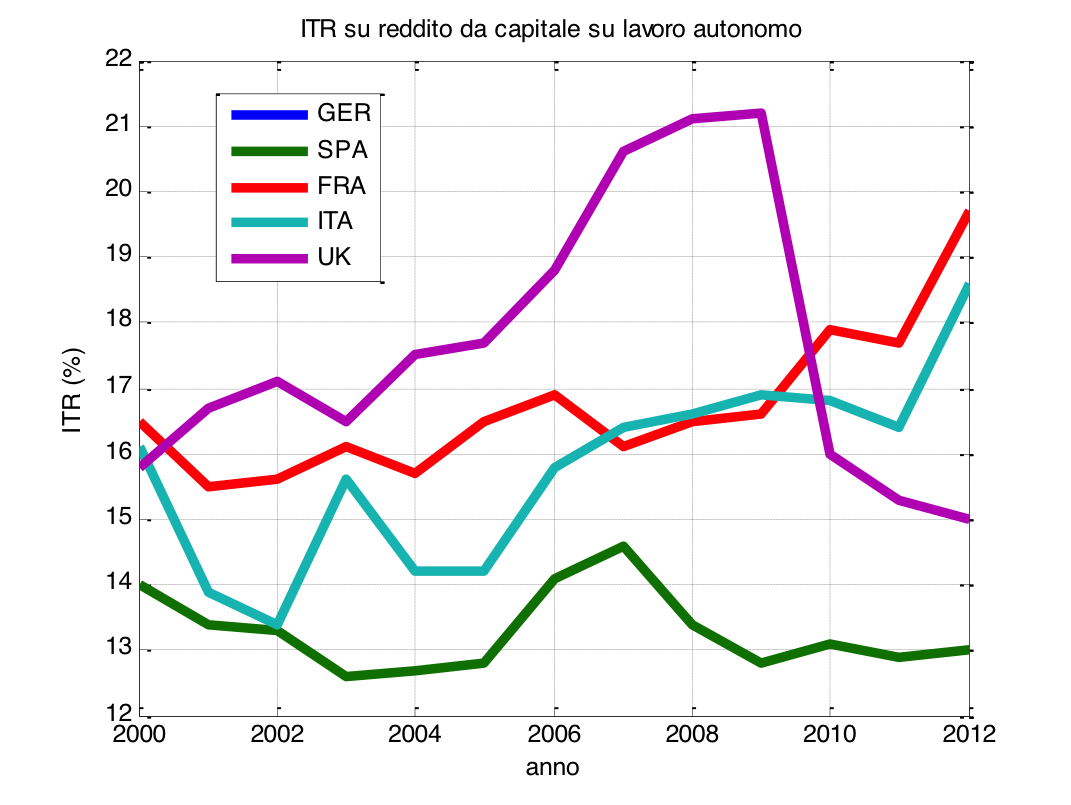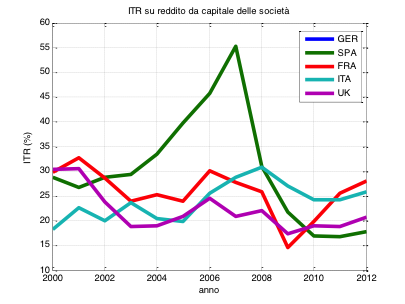Lo stato faccia la sua parte rilanciando gli investimenti
Enrico Cisnetto – Il Messaggero
Secondo il vocabolario le parole fiducia e credito possono avere lo stesso significato. In economia sono due facce della stessa medaglia. Se c’è fiducia ci sono investimenti, e se ci sono investimenti c’è credito. Ma se la fiducia manca, il credito latita. Non c’e dunque da stupirsi che di fronte al protrarsi della recessione, ora per di più abbinata alla deflazione, sia sceso il tasso di fiducia degli imprenditori italiani – a settembre quello calcolato dall’Istat è arrivato a 86,6 il livello più basso dell’ultimo anno – e che, di conseguenza non ci sia domanda di credito. Già, proprio mentre la Bce punta a rilanciare la spesa in conto capitale, privata e pubblica, spingendo le banche a dare più credito, il segnale che arriva alimenta più di un dubbio sulle future intenzioni d’investimento.
Siamo dunque nella paradossale situazione in cui la liquidità è enorme – mentre solo due anni fa parlavamo di credit crunch – ma rimane inutilizzata perché in giro non ci sono nuovi progetti. O meglio, in banca c’è la fila di chi vorrebbe credito per sistemare debito, e nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di aziende decotte, la cui crisi è stata solo accelerata dalla pessima congiuntura. Spiace dirlo, ovviamente, ma è bene che le banche, un tempo troppo generose come dimostra il livello delle sofferenze, non aprano quei rubinetti, perché quasi mai ci sono le condizioni del risanamento e del rilancio e quasi sempre si può al massimo prolungare di qualche tempo l’agonia, illudendo imprenditori e lavoratori.
Dunque, è infondata e sterile la polemica contro il sistema bancario che sento fare. Oggi le banche avrebbero tutto l’interesse ad azionare la leva degli impieghi, ma per farlo ci deve essere domanda di credito per nuovi investimenti, e non c’è. E quella poca che c’è finisce per dover pagare interessi elevati, che le banche devono praticare proprio per l’esiguità dei loro impieghi. Certo, ci può essere anche un eccesso di prudenza per paura di commettere i vecchi errori, ma il tema centrale è e rimane la mancanza di progetti. E allora, come si possono rimettere in moto gli investimenti e rilanciare la domanda? Occorre riaccendere la speranza che le cose possono cambiare davvero. E per farlo, dopo la stagione ormai consumata dei gesti simbolici, ci vogliono respiro programmatico e azioni concrete. Per esempio – e qui siamo alla seconda chiave di volta- lo Stato deve tornare a mettere mano al portafoglio. Per fare le cose strategiche, a cominciare dalle infrastrutture materiali e immateriali, che i privati non fanno. Come, visti i problemi di bilancio? Trasformando patrimonio pubblico e spesa corrente in spesa in conto capitale. È il modo più sicuro per dare credito alla fiducia.