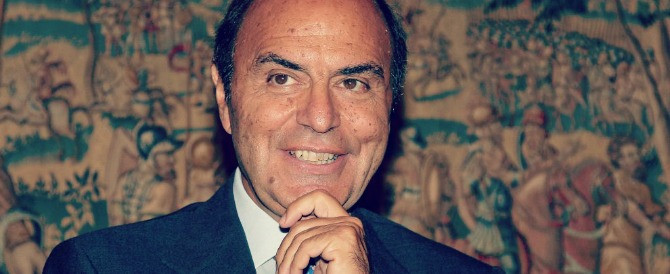L’innovazione industriale è tutta un flop, i fondi restano nel cassetto
Carmine Gazzanni – La Notizia
Inizialmente il fondo previsto era addirittura di 990 milioni di euro. Tra accantonamenti e tagli vari si è ridotto a 668 milioni. Ma, di questi, concretamente erogati sono poco più di 51. Stiamo parlando del clamoroso flop del fondo, gestito dal ministero dello Sviluppo Economico, creato nel 2007 con la finalità di sostenere e lanciare le imprese indirizzandole verso scenari più competitivi e tecnologici. Non a caso il nome: Progetti di Innovazione Industriale.
Un programma di tutto rispetto che, negli intenti, avrebbe dovuto essere indirizzato a interventi in ben cinque aree tecnologiche considerate strategiche: “efficienza energetica”, “mobilità sostenibile”, “made in Italy”, “tecnologie della vita” e “beni e attività culturali e turistiche”. Il sistema era relativamente semplice: il ministero mette a disposizione i soldi, il privato presenta progetti che la struttura burocratica preposta vaglia, infine viene concesso il finanziamento. Qualcosa, però, non deve aver funzionato. Anzi, più di qualcosa. Cominciamo dal finanziamento. Tramite decreto ministeriale dell’11 luglio 2007, si decide di investire, e tanto, con uno stanziamento da 990 milioni di euro. Una montagna di soldi. Ma ben venga se serve a lanciare l’industria. Peccato però che, causa crisi, il fondo viene drasticamente ridotto. Secondo il rapporto trasmesso proprio in questi giorni dal MiSE al Parlamento, i soldi realmente messi a disposizione sono calati, come detto, a 668 milioni. Poco male, si penserà: parliamo sempre e comunque di un bel gruzzoletto.
Ma ecco il punto: dal 2007, con ben 5 macroaree a disposizione, quante erogazioni effettive saranno state fatte? Il dato emerge dal citato dossier: i soldi concretamente concessi alle imprese private arrivano, nel giro di sette anni, a soli 51 milioni. Briciole, insomma. Basti questo: rispetto al fondo iniziale previsto (990 milioni) parliamo del 5% erogato. Ma non è finita qui. Dei 232 progetti ammessi al fondo, ad oggi, al netto di sospensioni e rinunce, rimangono in vita solo 174. Un po’ pochini. Soprattutto se si considera che, in sette anni, due delle cinque macroaree non sono mai partite: stiamo parlando di “Tecnologie della vita” e “Tecnologie per i beni e le attività culturali e turistiche”. Partiranno prima o poi? Ce lo dice lo stesso rapporto: “permangono fondate perplessità sulla futura concreta attuazione dei due PII non ancora adottati”. Evviva.
Di chi le responsabilità, difficile dirlo. Fatto è che negli anni si sono alternati una serie di enti di controllo: Ipi, Cilea, Invitalia e comitati ministeriali vari. Fino al 2010 (a tanto arriva il rapporto) sono costati 35 milioni. È facile supporre che nel giro di ulteriori 4 anni, i costi di funzione siano perlomeno raddoppiati. Insomma, un fondo bruciato il cui costo di gestione è stato maggiore a quanto erogato. Chiamasi “innovazione industriale”.