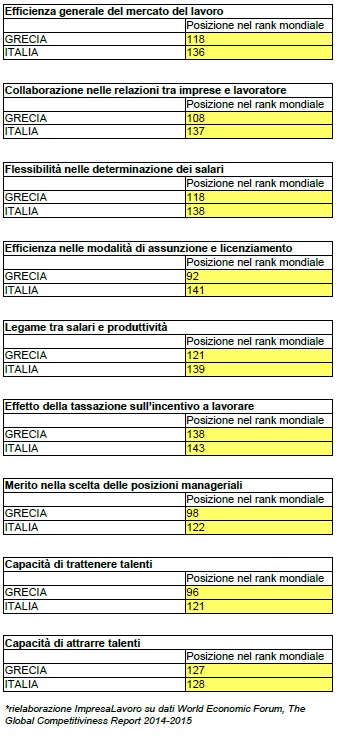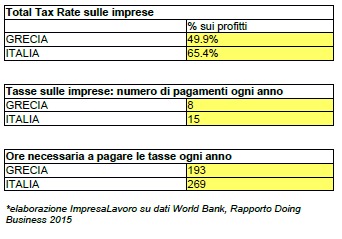Pedinamento video e dossier, il detective incastra i fannulloni
Giacomo Susca – Il Giornale
«Con questa crisi, mi dica chi può permettersi di pagare qualcuno che non lavora o che fa finta di lavorare… eliminare le mele marce è questione di sopravvivenza. Se rubi lo stipendio, o te ne vai o l’azienda chiude». Il concetto, messo così, è brutale e pare quasi scontato. Però non viene dal politico anticasta o dal tecnico del ministero a caccia di tagli. Parlano i nuovi professionisti chiamati in causa nella lotta all’assenteismo. Sono gli investigatori privati: rappresentano l’ultima frontiera esplorata da quegli imprenditori, ma anche da quei dirigenti di società partecipate, che mai come ora si sentono «abbandonati dallo Stato».
Nel privato il fenomeno dell’assenteismo è più circoscritto rispetto alla giungla del pubblico impiego – i dati dell’Inps dicono che i certificati di malattia trasmessi nel 2013 sono aumentati in questo settore «solo» dell’1,1% rispetto al 2012: in valore assoluto sono stati 11.869.521, con 8,9 milioni di «eventi di malattia», che si traducono in genere dai 2 ai 10 giorni di assenza consecutivi. Ma i responsabili di impresa non hanno più tempo (e denaro) da perdere, per cui hanno preso a farsi «giustizia» da soli, assoldando detective e consulenti di intelligence pur di stanare i fannulloni ancora a libro paga. Se le istituzioni latitano e la morsa dei controlli si allenta, bisogna darsi da fare in proprio.
Le indagini sulle «corna» sono il retaggio di un passato imprigionato ormai quasi solamente in vecchi film; oggi è sufficiente un’occhiata al cellulare e ai social network per smascherare un partner infedele. L’infedeltà e la scorrettezza ben più difficili da individuare e punire sono quelle del dipendente fraudolento o scansafatiche. Il core business delle agenzie investigative, che negli ultimi anni registrano tassi di crescita anche a doppia cifra come dimostrano alcune indagini delle Camere di commercio, si è decisamente spostato sul terreno aziendale. Basta fare un giro sui principali motori di ricerca in internet per rintracciare almeno una cinquantina di società specializzate a Milano e a Roma, ma pure all’interno dei distretti più produttivi, come in Veneto, Toscana, Emilia-Romagna. In tutto il territorio nazionale sono 600-700 le realtà che operano soprattutto in questo specifico ambito.
Dove non arrivano le leggi, l’ispettore Inps o il medico fiscale, è l’investigatore privato a verificare se le astensioni dal lavoro per motivi di salute o personali non nascondano in realtà malcostume e truffe. «Il 40% delle nostre indagini aziendali si concentra sull’assenteismo dei dipendenti. L’obiettivo è raccogliere prove documentali che possano essere utilizzate in giudizio dall’azienda che intende procedere al licenziamento del dipendente per giusta causa, oppure seguire vie extragiudiziali come la richiesta di risarcimenti o di dimissioni», spiega Marzio Ferrario, ceo dell’agenzia Phersei. La Cassazione, con la sentenza 25162 dello scorso novembre, è tornata a occuparsi della materia: ha ribadito che è legittimo il licenziamento del dipendente che, in malattia, «nei giorni di assenza compiva attività logicamente incompatibili con la patologia stessa – come sollevare una bombola a gas, cambiare una ruota, prendere in braccio la figlia». E i giudici hanno sdoganato definitivamente l’utilizzo degli 007: «È legittimo il ricorso a un’agenzia investigativa da parte del datore di lavoro per assumere queste informazioni», naturalmente nel rispetto delle norme sulla privacy.
«Nel 2014 i mandati per contrastare l’assenteismo sono cresciuti del 7%. Si rivolgono a noi aziende italiane, ma anche straniere con interessi commerciali in Italia – raccontano Francesco e Davide Castro, padre e figlio, responsabili dell’agenzia Vigilar Group -. Non possiamo fare i nomi delle aziende per due motivi: sia per il contratto di riservatezza che ci lega al cliente, sia perché si preferisce non far sapere ai propri dipendenti che potrebbero essere “attenzionati” o sorvegliati». Si tratta comunque di grandi gruppi aziende del settore automobilistico, case di moda e di lusso, multinazionali farmaceutiche e dell’energia. Il modus operandi delle agenzie può essere riassunto così: imprenditori e capi ufficio del personale espongono il loro «problema», che corrisponde a un nome e cognome, il lavoratore o la lavoratrice sospettata di fare imbrogli con malattie o permessi.
Dopo una prima fase di indagini preliminari sul soggetto (con l’utilizzo di fonti aperte, compresi colleghi e conoscenti, e altre più strettamente confidenziali), partono i primi sopralluoghi e quindi il «controllo diretto» (anche con il più classico dei pedinamenti), svolti in alcuni casi da una squadra di due o più detective. Vengono scattate foto e girati video per fornire elementi di prova incontrovertibili; infine, gli investigatori riportano l’esito delle indagini in un dossier che potrà essere utilizzato in un’eventuale azione legale. «I servizi di surveillance hanno durata variabile, ma solitamente in 4-5 giorni siamo in grado di fornire un quadro completo della situazione», conferma Davide Castro.
Il risultato è che se ne vedono di tutti i colori: il dipendente assente per malattia che malato non è, ufficialmente influenzato va in palestra o alle terme; c’è chi dice di avere un braccio rotto e poi vince il torneo di tennis in Brianza. E poi ci sono quelli che approfittano dei congedi in virtù della legge 104, ovvero dei permessi retribuiti per assistere un familiare portatore di handicap.
Ma invece di stare accanto alla madre disabile, si concedono una giornata di shopping, vanno al parrucchiere, qualcuno è stato sorpreso a farsi una gitarella in una città d’arte a 500 chilometri di distanza dal domicilio. «Per non parlare di quel “lavoratore” che andava a trovare una escort con una certa frequenza…», ricorda divertito un investigatore romano. In una diversa forma di assenteismo rientrano i casi di dipendenti che sarebbero al lavoro ma in realtà fanno altro, «attività non inerenti all’interesse dell’azienda». Come l’informatore scientifico che non rispetta gli appuntamenti in agenda e si dedica ad altri affari: «Ce n’era uno che passava le giornate a coltivare campi di kiwi…», confida divertito un altro detective. I sospetti «mirati» dei datori di lavoro vengono confermati dalle indagini sul campo nel 90% dei casi. Una singola agenzia con un buon parco clienti e di dimensioni medio-grandi, in un anno può contribuire al licenziamento per giusta causa anche di 50 «furbetti» a vario titolo. Attenzione, non solo semplici impiegati col vizietto di imboscarsi, ma pure top manager. Secondo l’osservatorio sulle investigazioni di Axerta Investigation Consulting, «nell’83% delle indagini svolte il lavoratore tiene un comportamento scorretto, il 92% mette in atto comportamenti che compromettono la guarigione e l’8% si mette in malattia per fare un altro lavoro». Dal punto di vista delle aziende, lo sforzo economico di affidarsi alle agenzie vale «l’impresa» – appunto – in termini di indennità di malattia o di stipendi risparmiati.Il pregiudizio inganna, ma a volte anche la statistica. Gli studi incrociati tra i paesi Ue e Ocse inquadrano l’Italia, a sorpresa, tra i livelli più bassi di assenteismo. O meglio, succede che da noi è minima l’assenza media ma massimo il differenziale tra pubblico e privato. L’Inps nell’ultimo rapporto certifica che nel 2013 sono stati trasmessi dalla pubblica amministrazione 5.983.404 certificati medici. Considerando che gli statali in servizio sono oltre 3,3 milioni, significa una media di 1,8 certificati a testa, tornati a crescere a un tasso del +27% in due anni. E le prime indiscrezioni sui dati 2014 confermano la tendenza, visto che sono saliti ancora del 9,4%. I dipendenti del settore pubblico si assentano per malattia circa dieci giorni all’anno contro i sei del privato. Qualche meccanismo si deve essere inceppato, visto che almeno fino al 2011 gli effetti positivi della riforma Brunetta si erano visti, avendo portato a una riduzione media dei giorni di assenza per malattia pari al 31,1%. La rivoluzione della legge 133 del 2008, a quanto pare, è già un ricordo e oggi siamo punto e a capo. L’impatto delle misure va esaurendosi col tempo insieme al loro effetto deterrente.
Anche se è guerra di numeri. Il ministero della Pubblica amministrazione ne ha diffusi di nuovi la settimana scorsa, secondo cui le assenze sarebbero calate del 5% nel 2014 ma da questo conteggio restano fuori comparti chiave e ad «alta densità» di assenteismo come la scuola. Ogni anno le indennità di malattia riconosciute alle aziende costano all’Inps qualcosa come due miliardi di euro. E Confindustria ha calcolato che «portando l’assenteismo nel settore della Pa sui livelli più bassi delle imprese private si risparmierebbero oltre 3,7 miliardi di euro di spesa, attraverso un minor fabbisogno di personale». O quanto meno, a parità di costi, un minore assenteismo aumenterebbe l’efficienza e la qualità dei servizi. Numeri da capogiro per abbattere i quali si fa poco o niente.
Esemplare il caso dei vigili urbani di Roma. La magistratura ha aperto un’inchiesta sulla «sbornia di Capodanno» per capire se l’ammutinamento fosse premeditato e se ci sia stata la regia dei sindacati. Uno specchio della difficoltà a prendere provvedimenti incisivi. Ecco un’altra prova: in tutto il 2013 sono 220 i dipendenti della pubblica amministrazione licenziati in seguito a quasi settemila procedimenti disciplinari. Eppure sono appena 99 gli allontanamenti legati ad assenze ingiustificate o non comunicate nei tempi previsti. Altri 1.400 lavoratori (si fa per dire…) se la sono cavata con una sospensione, che si traduce in giornate senza stipendio, più raramente settimane. Finora hanno sempre pagato in pochi (uno ogni 15mila!).
Adesso il governo torna all’attacco brandendo il disegno di legge Madia, che ripropone il licenziamento senza preavviso per la falsa attestazione della presenza in servizio o l’assenza ingiustificata con falso certificato medico. Insomma, si tenta di riscrivere quelle regole che negli ultimi non si è quasi mai riusciti ad applicare. E questo i fannulloni, di Stato e no, lo hanno capito molto bene.